 Gas serra
Gas serra
Sono detti gas serra quei gas dell’atmosfera terrestre, di origine naturale o antropica, che sono trasparenti alle radiazioni solari in entrata ma sono in grado di trattenere, in modo consistente, le radiazioni infrarosse emesse dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle nuvole. Questa loro proprietà è nota come effetto serra.
I principali gas serra presenti nell’atmosfera sono il vapore acqueo (H2O), l’anidride carbonica (CO2), l’ossido di di azoto (N2O), e il metano (CH4). Le emissioni di questi ultimi tre gas serra sono regolamentate dal protocollo di Kyoto. Spesso l’ozono (O3) è confuso tra i gas serra, ma in realtà esso non trattiene le radiazioni infrarosse, ma filtra invece i raggi solari UVB e UVC.
Vi sono poi molti gas rilasciati nell’atmosfera terrestre dall’attività umana come gli alocarburi, tra cui i più comuni sono i clorofluorocarburi (CFC) utilizzati fino alla metà degli anni ’80 come propellenti per bombolette spray, e tante altre molecole contenenti cloro e fluoro. Le emissioni dei gas alogenati, regolamentate da un trattato internazionale firmato nel settembre 1987, il protocollo di Montreal, sono molto inferiori rispetto agli altri gas serra e la loro concentrazione nell’atmosfera è molto bassa, ma questi gas possono avere un tempo di vita molto lungo, anche fino a 400 anni, e un grande effetto come forzanti radioattivi, da 3.000 a 13.000 volte superiore dell’anidride carbonica. Il forzante radioattivo è la misura d’influenza di un fattore nell’equilibrio tra energia entrante ed energia in uscita nel sistema terra-atmosfera. Il calcolo della misura in cui un gas serra contribuisce all’effetto serra, il Global Warming Potential (GWP, potenziale di riscaldamento globale) è effettuato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo Consulente Intergovernativo sul Mutamento Climatico) per convertire le emissioni di gas serra in emissioni di CO2 equivalenti.



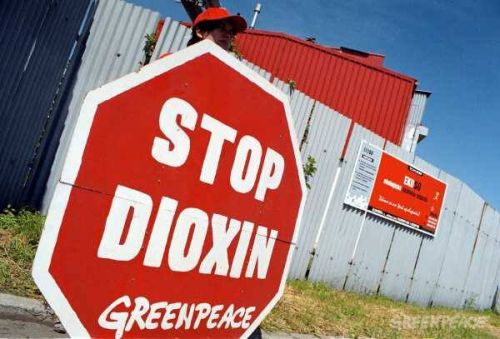





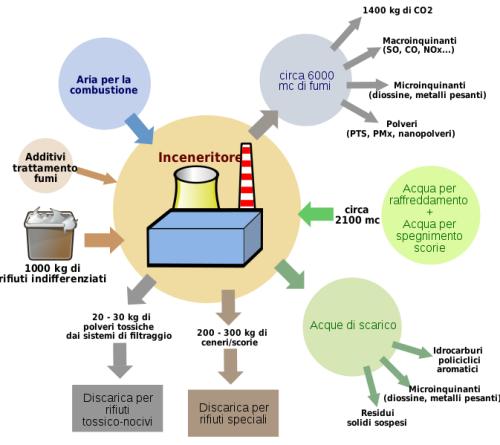







 Discarica
Discarica





